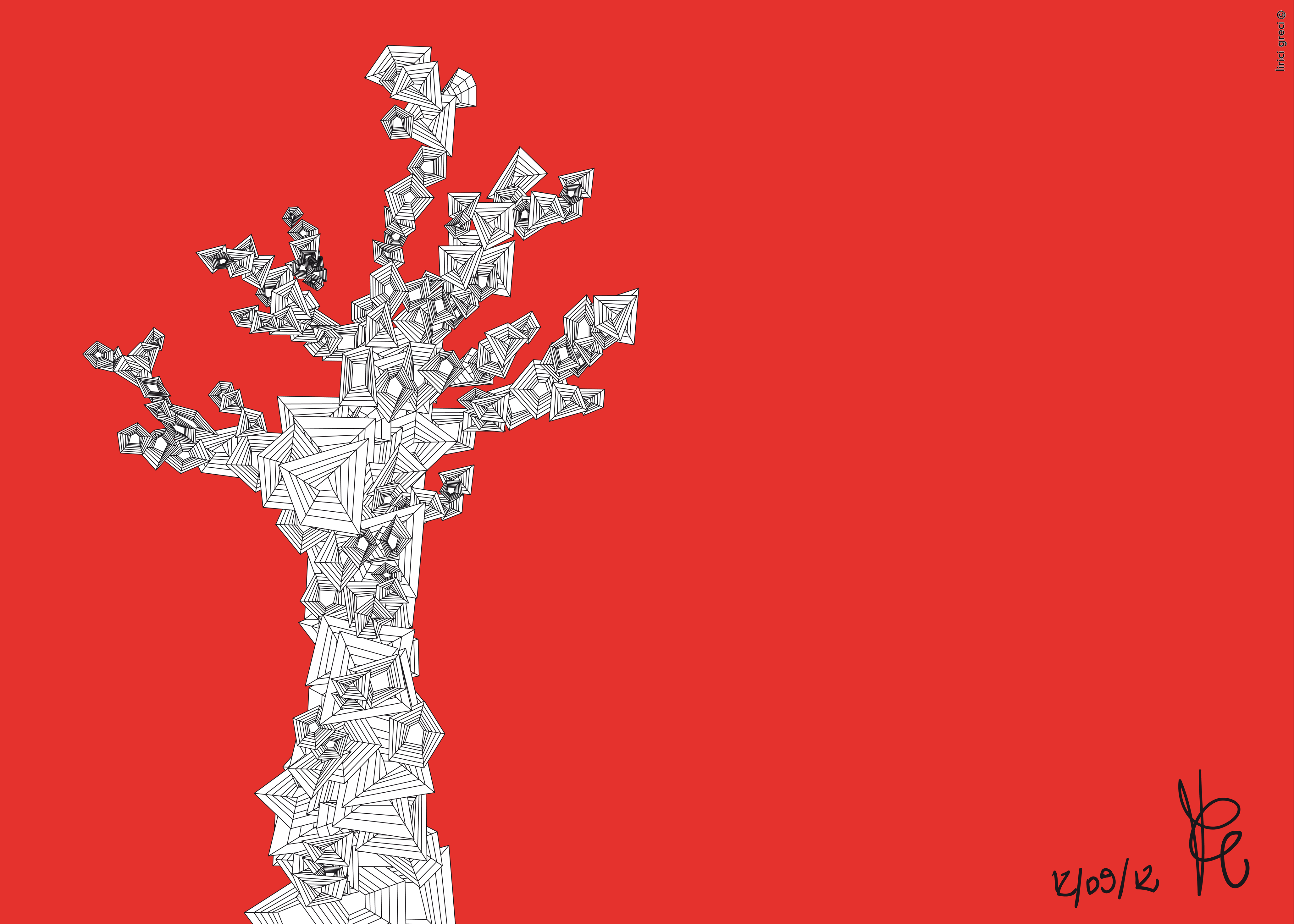Cristina Babino con Marco Puca
Da nostro lunedì num. 1 nuova serie
Leopardi. Il pensatore pericoloso

Dovevo sedere tra i banchi delle elementari. Avevo otto anni, o poco più, e una maestra materna e illuminata, di quelle ancora “di una volta”, che assecondava quotidianamente la mia inclinazione per le parole e la lettura. Allora quella figura, tratteggiata alla buona in un bianco e nero modesto e un po’ sbiadito, che mi volgeva le spalle dalle pagine del sussidiario, rivolta a una luna chiara e lontana, mi attirò con la sua aria a un tempo intenta e ignara. Cosa e quanto potesse capire una bambina di otto anni della poesia di Giacomo Leopardi non so, e non saprei dirlo. Ma posso dire che un passaggio, non proprio un verso, mi colpì con la forza inaudita di una scoperta, di una rivelazione. A me la vita è male. Ho sempre pensato, negli anni che sono seguiti, e penso ancora oggi, che quelle sei parole siano state per me l’incontro della vita. L’incontro con la poesia, con ciò che significa fare poesia, ricercare quell’unica parola necessaria, portatrice di quell’esatto significato a cui si aspira, veicolata per mezzo di quell’unico possibile “giusto” suono. La bellezza. Di una lingua senza inciampo, sbavatura. Apparentemente senza sforzo. Anche quando è una lingua che afferma una verità così terribile, definitiva, assoluta. A me la vita è male. Non so pensare un verso più compiuto di questo, più esatto nella sua schiettezza semplificata eppure profondissima, una perfezione più grande, una coincidenza più convincente tra suono e intenzione, un nodo più simmetrico e armonico di significato. Certe cose che leggi, che ti trovano, sollevandosi dalla pagina scritta, e in cui fatalmente riconosci un po’ di te, ti seguono, risuonano, infine ti ritrovano. Anni dopo, da studiosa, meditando sull’infinita traduzione del Qohélet curata da Guido Ceronetti, riconobbi in quelle poche, spesso neglette, pagine perse nel mare del canone biblico, nella loro pronuncia secca, nel loro dettato aspro e sferzante, tanta parte di quelle melodiche, amare divagazioni che il pastore errante dell’Asia indirizza alla sua indifferente, silenziosa luna. Ho riscoperto, nella scarna prosa dello scritto sapienziale, la stessa dialettica tra un infinito e un finito ugualmente privi di prospettiva, allo stesso modo volti a una fine ineluttabile e incomprensibile, la medesima invidia per il mondo animale e vegetale, libero da rovelli e interrogativi, sciolto dal peso del pensiero, la stessa rassegnata avversione per una natura indifferente al male umano, ignara dei suoi meccanismi ineluttabili e feroci. Tutte le cose sono in travaglio dice Qohélet. A me la vita è male: è il pastore che parla, che prende adesso la parola, nella sua assemblea muta con la luna. Un sermone, il suo, tanto più universale quanto più è introflesso, interiorizzato. Come un nuovo Ecclesiaste, moderno e profano. E forse in questo ancor più sacro. Continua a leggere→