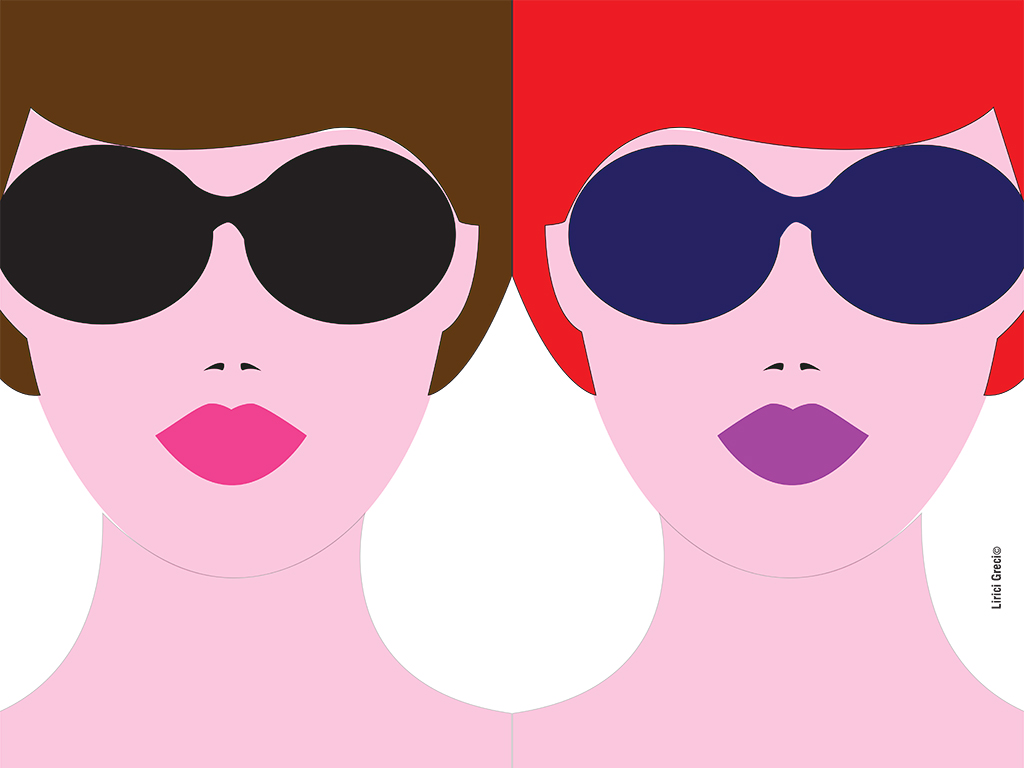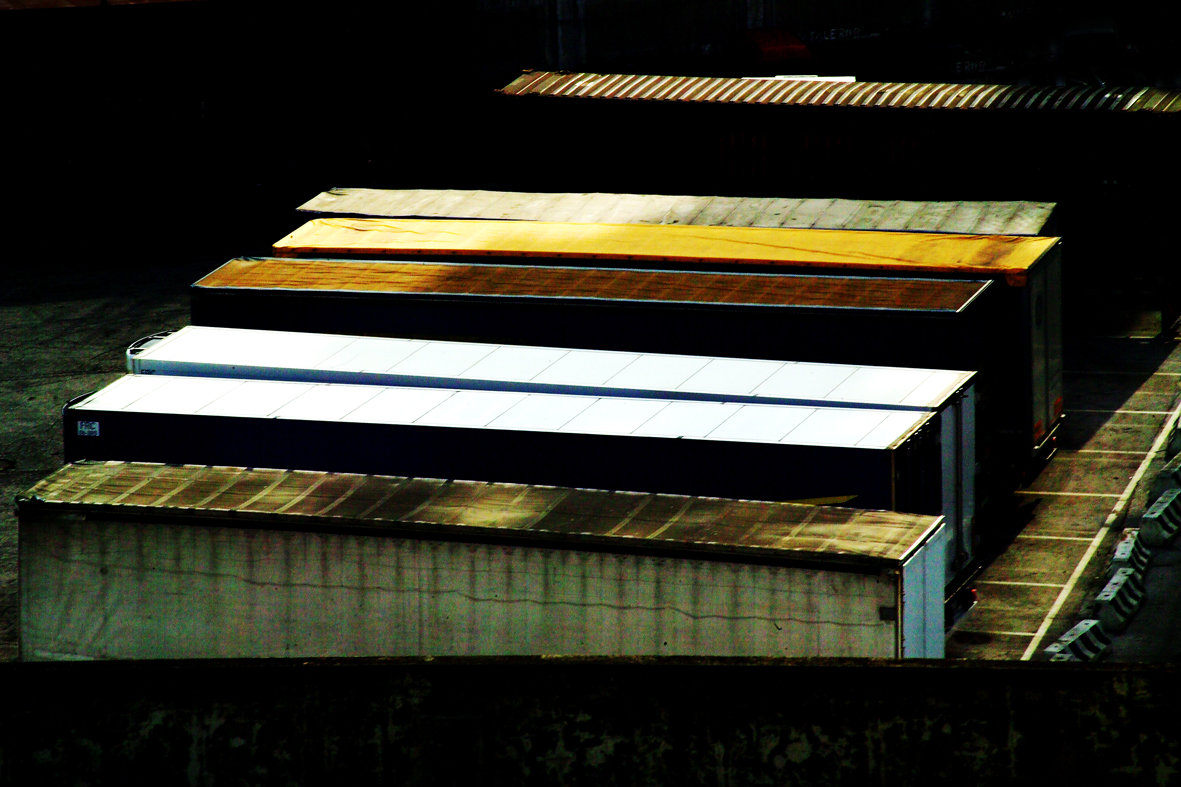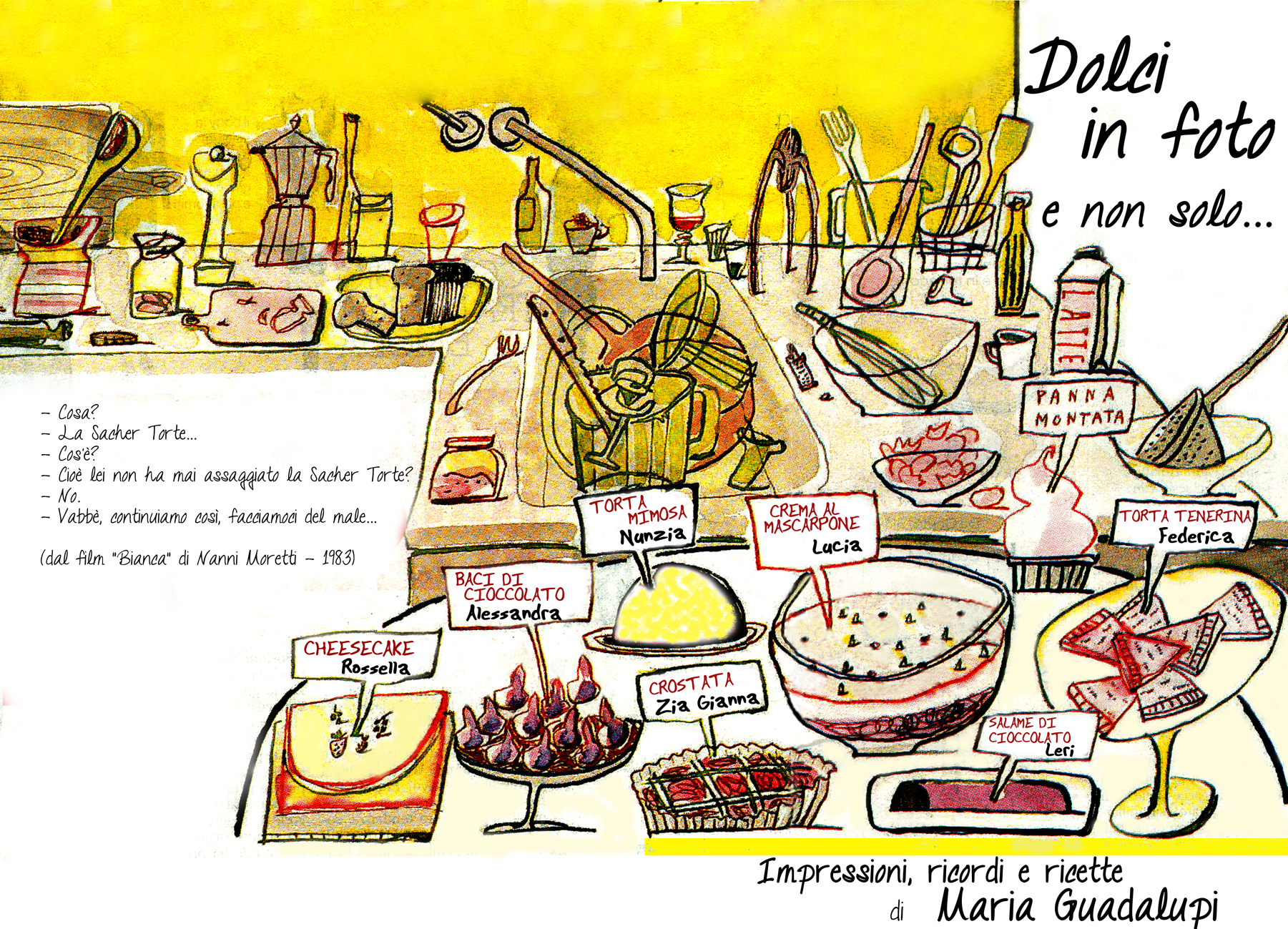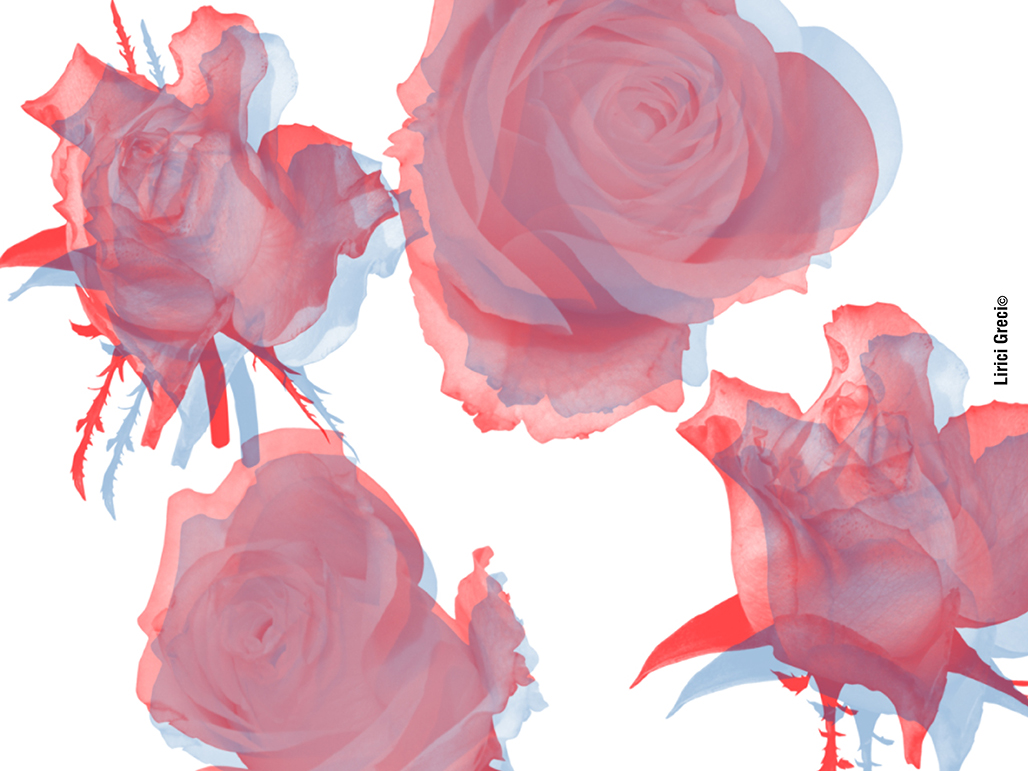Batouly li aspetta al settimo piano. Per raggiungerlo salgono tutti e tre in ascensore, scendono, e quando le porte metalliche della cabina si aprono scorrendo a sipario, Batouly è lì sul pianerottolo che compare in tutta la sua fantascientifica stazza nera.
Ha la testa pelata, gli occhiali scuri e indossa una camicia gialla e dei pantaloni neri righettati da una sottile filigrana dorata. L’effetto complessivo del suo abbigliamento è piuttosto kitsch ma efficace. Felpa rossa e felpa nera non scendono dall’ascensore, guardano Pacifico fare un passo avanti e sgusciare dalla cabina e lo salutano con un “ci vediamo dopo”, mentre le portiere già si richiudono.
Batouly inizia subito a parlare di sé, senza che Pacifico dica niente. Fa l’operaio ma è in cassa integrazione e ha la mattinata libera. Oggi è un giorno infrasettimanale e lui vorrebbe essere in fabbrica. Lavora in una ditta di stampi per gomma. “Facciamo soprattutto suole per le scarpe. Qui la gente che sta in fabbrica lavora tutta nella plastica”. Racconta che una volta, di mattina, qualche anno fa, i padroni arrivavano a reclutarli fin sotto l’Hotel Residence. Quelli che cercavano lavoro si facevano trovare raggruppati nel cortile dell’Hotel, i capifabbrica venivano in macchina e sceglievano la manovalanza. Assumevano tutta la gente di cui avevano bisogno per mandare avanti le catene di montaggio. Ma oggi davanti ai portoni di ingresso del Residence non viene più nessuno, i macchinari nelle fabbriche sono fermi e nel cortile ci trovi solo i vecchi seduti sulle panchine con le barbe bianche e gli occhi piccoli e le donne che passano cariche di buste e i bambini che giocano a frotte, rincorrendosi. Ci sono poi gli italiani che vengono a prendersi ero e coca dagli spacciatori. Ma quelli orbitano tutti nel cortile accanto, perché l’Hotel Residence è una struttura a croce e di cortili ne ha quattro. Nel secondo cortile, che è verso nord, ci stanno tutti gli spacciatori. Sono magrebini più che altro, ma anche africani o slavi. D’inverno dal cortile si spostano dentro il Residence, nei primi piani, e da lì non si muovono. Gli italiani entrano dentro, comprano la roba e escono.
Bautoly racconta della droga nel palazzo a fatica, si vede che l’argomento gli costa sofferenza. La sua parlata incede insicura, il suo accento africano si fa straripante. In ogni sillaba infila vocali troppo aperte o troppo chiuse, schiacciate e nasali. Il ritmo delle frasi è sincopato, imprevedibile, per questo è magnetico alle orecchie di Pacifico. Cambia discorso e dice: “Ti devo far vedere una persona che sta qui, lui ha sempre bisogno di compagnia. È un mio amico. Ora è solo, sua moglie è via”. Bussano ad una porta, nel fondo di un corridoio pieno di altre porte allineate. L’uscio si apre e c’è un uomo altissimo, nero anche lui, anche lui senza capelli, africano, dalla pelle più nera di Bautoly. Ha gli arti slanciati e robusti e un volto dai tratti orgogliosi. Ma subito si percepisce che qualcosa in lui è rotto. Muove gli occhi in continuazione, non riesce a tenerli fermi, poi però inizia a fissare Pacifico, ferma le pupille su di lui, apre appena la bocca e il labbro inferiore gli casca pendulo in avanti, umido. Batouly dice all’uomo qualcosa in francese.
Poi l’uomo li fa entrare.
Il suo appartamento è spoglio, trasandato. C’è un senso d’abbandono impresso sui muri. Batouly indica Pacifico e dice: “Questo è un mio amico, è venuto stamattina per conoscerci, conoscere noi che viviamo qui al Residence. Dice che vuole sapere come si vive qui. Me l’hanno portato i figli di un mio collega di lavoro rumeno”. L’uomo continua guardare Pacifico, ha la pelle della testa screpolata, è come se il suo cranio fosse avvolto da una leggerissima ragnatela. Resta interdetto, si interroga sui motivi profondi che muovono la curiosità di Pacifico, lo si capisce dalla luce densa che gli riempie gli occhi. Fuori, oltre il balcone e la finestra, Pacifico osserva di sfuggita la costa sabbiosa dipanarsi in lontananza. La spiaggia e il mare si congiungono lungo un filo impalpabile, bianco, fatto di spuma. “Io non esco mai da qui – esordisce l’uomo – sì, cioè, esco quando vado al lavoro, ho un contratto con un supermercato per caricare e scaricare. Anzi, più tardi mi inizia il turno. Ma qui al Residence non conosco nessuno. Mia moglie ora non c’è, lavora anche lei – L’uomo si ferma un attimo, riprende fiato – Dobbiamo lavorare tutti e due perché nostra figlia sta male. Dobbiamo darle le medicine. Se fossimo in Senegal sarebbe già morta, mia moglie me lo ripete sempre. Nostra figlia ha una forma di diabete. Qua i servizi sociali del Comune le danno le medicine”. L’uomo è tormentato dalla infelicità della figlia, in lui si agitano visioni interiori convulse, a tratti atroci. Pacifico gli osserva le gambe, i suoi femori sono altissimi. L’uomo siede su uno sgabello e le ginocchia arrivano quasi all’altezza della bocca di Pacifico che si trova su un divano sfondato. L’uomo è stanco ma i suoi lineamenti sembrano cristallizzati, fermi, bloccati in un coma fisiologico che li astrae dal tempo. Muove le gambe e poi torna a ripetere che sta male, che così non va. Alterna fasi di silenzio a scuotimenti di testa, si passa le mani sulla pelle tesa e screpolata del cranio. Sostiene che in Senegal era un diplomatico, viveva in una via piena di belle case azzurre e di cortili nascosti. Poi torna a parlare della figlia, tira fuori da un cassetto un foglio di carta. Dice, “questa è mia figlia, vedi, ha il diabete, ma io e mia moglie non riusciamo a curarla. Ci hanno aiutato anche i preti in paese, c’è un sacerdote molto grasso che ci ha portato dai servizi sociali. Io vorrei tornare in Senegal. Lì non mi mancava niente, ero un uomo importante”. Dice che è emigrato in Italia solo per provare, perché ha avuto la possibilità e allora è partito. “Perché sono matto – ripete – perché sono matto. Sono arrivato in Italia, poi mia moglie mi ha raggiunto e quando è nata nostra figlia già ci eravamo trasferiti nel Residence. Mi sento morire se penso a mia figlia”. L’uomo rimane fermo, seduto sulla sedia. Prova tenerezza per la figlia sofferente, ma è un amore straziato dall’angoscia, dalla paura della malattia. Anche se agli occhi di Pacifico la pelle nera dell’uomo resta una membrana impenetrabile, uno strato di materia organica che pone il suo interlocutore in una galassia lontanissima, Pacifico intuisce l’amore e la paura, l’angoscia che deturpa l’animo dell’uomo.
È una percezione che crea un varco, e al di là della sua pelle nera come la notte, Pacifico sente come di conoscere quell’uomo da sempre.
Poi Batouly dice a Pacifico che vuole portarlo ancora da un’altra persona. Così salutano l’uomo che li accompagna silenziosamente alla porta. Escono, gli androni del Residence sono ancora deserti, sprofondati in una luce acquosa e verdognola dove ogni parola si fa eco ovattato. Prendono ancora le scale e Pacifico tuffa lo sguardo tra la moltiplicazione delle rampe che si incrociano. I corrimano scendono paralleli e disegnano, uno di fronte all’altro, una sottile fessura vuota, uno spazio di nessuno che ha il taglio di un occhio dalla profondità architettonica annichilente. Scendono per un paio di piani, bussano ancora a una porta e questa volta ad aprire è una donna, africana anche lei, con una camicia bianca sopra il corpo florido, giovane, prospero. La donna ha un sorriso indifeso e due fossette tenere come more nel mezzo delle guancie. Tiene gli occhi bassi, mentre fa accomodare Pacifico e Batouly nel tinello del suo appartamento. Nella stanza c’è una credenza dai portelloni di vetro, molto vecchia ma ricolma di piatti e di bicchieri colorati. “Questa casa – dice la donna – è di una signora italiana che ce l’affitta, ma per pochi soldi. Qui lei non ci viene più”. Fa l’aiuto cuoca in un ristorante della zona, le piace. Si muove festosa, come la chioma d’un albero abituata ad accogliere i soffi del vento. “E tua figlia come sta? Spiega al signore di lei. Il signore è qui per conoscere le nostre storie” le dice Batouly indicando Pacifico. “Mia figlia sta bene, va all’asilo. L’hanno operata al cuore quando era neonata – inizia a raccontare la donna come se nulla fosse – Aveva un problema a una valvola cardiaca, era piccolissima. Per fortuna ci hanno aiutato, siamo riusciti a portarla all’ospedale Niguarda, a Milano. E ora tutto è finito. La gente della città mi ha aiutato. Io qui ero sola”. La donna non sembra scomporsi a quel racconto, anzi è serena, felice di ricordare qualcosa di brutto che ora è scomparso e non c’è più e che è stato sconfitto. A quel punto si apre la portafinestra del balcone. Entra un uomo, anche lui africano. Ha dei baffi rassicuranti, folti. Il sole del tardo mattino rischiara di luce la sua pelle nera. “È mio marito, cerca lavoro. Mi ha raggiunto in Italia da poco e ancora non riesce a parlare l’italiano”, dice la donna che, incalzata da Batouly, continua a parlare, anzi sembra in preda a una improvvisa allegria: “Che vita che facciamo qua. Nei primi piani del Residence d’inverno è pieno di spacciatori nascosti nel buio. Stanno soprattutto al primo e al terzo piano. Qualcuno fa la vedetta ai balconi dei piani alti e appena arrivano le macchine della polizia le vedette avvertono gli spacciatori che si vanno a chiudere dentro i loro appartamenti. La gente sale e scende continuamente le scale per comprare la droga. E poi ci sono le perquisizioni della polizia, arrivano a sirene spiegate e la notte succede di tutto, qua. Una volta sono entrati anche dentro casa mia e ho avuto una paura che stavo per morire. Non avevo ancora tutti i documenti in regola e ho pensato adesso mi rimandano in Senegal. Oh che paura che ho avuto. Noi immigrati abbiamo sempre paura della polizia”. La donna ha i fianchi levigati e floridi sotto la camicia bianca e i capelli raccolti in due trecce nere che le scendono sul petto. Il marito non dice niente, lei si alza e va in un’altra stanza e quando torna mostra a Pacifico una piccola foto, di una bambina contornata di giocattoli che siede su un tappeto. “Qui è mia figlia all’asilo, l’anno scorso. È lì anche adesso, tra poco passo a prenderla prima di andare al lavoro”. L’appartamento della donna ha le pareti imbiancate di fresco, sopra le mensole e negli angoli giacciono alcuni soprammobili scoloriti dal tempo, forse slavati dall’aria salsedinosa che viene del mare. Pacifico li osserva un attimo, sono oggetti semplici che però tessono una narrazione invisibile in tutta la stanza.

Marco Benedettelli
Marco Benedettelli, giornalista professionista, collabora con varie testate nazionali.
E’ fra i fondatori e direttore responsabile di “Argo, rivista di esplorazione”.
Nel 2012 ha pubblicato la raccolta di racconti La regina non è blu.
www.argonline.it
www.ibs.it
info@nostrolunedi.it
www.nostrolunedÏ.it
info
info@liricigreci.it
www.liricigreci.it